Il mercato (emerso e sommerso) del recupero anni scolastici
giugno 26, 2017 in Approfondimenti da Sonia Trovato
 Davide ha diciassette anni e vive in un riformatorio che lo vuole diplomato a tutti i costi, sebbene abbia abbandonato gli studi dopo una prima superiore ripetuta tre volte. Yan è cinese, di anni ne ha diciannove e, a causa di un lungo viaggio nella città natale, ha perso quattro anni di scuola. Davide e Yan sono due nomi inventati per raccontare una storia vera, quella, cioè, dell’inquietante realtà degli istituti di recupero degli anni scolastici e di come disgraziatamente vi incappai lo scorso settembre.
Davide ha diciassette anni e vive in un riformatorio che lo vuole diplomato a tutti i costi, sebbene abbia abbandonato gli studi dopo una prima superiore ripetuta tre volte. Yan è cinese, di anni ne ha diciannove e, a causa di un lungo viaggio nella città natale, ha perso quattro anni di scuola. Davide e Yan sono due nomi inventati per raccontare una storia vera, quella, cioè, dell’inquietante realtà degli istituti di recupero degli anni scolastici e di come disgraziatamente vi incappai lo scorso settembre.
Avevo discusso da pochi mesi una tesi di dottorato in letteratura italiana e concluso da quasi un anno la borsa di studio, che aveva costituito il mio stipendio per i tre anni di ricerca. «Ora che sei laureata puoi cercarti un lavoro» dicevano i parenti e alcuni amici, che non avevano mai attribuito l’etichetta “lavoro” alle mie giornate in biblioteca a parafrasare l’Orlando furioso. Per chi pensava che fossi fuoricorso e per chi invece credeva che mi stessi prendendo una seconda laurea la conclusione era la stessa, e cioè che solo ora, alla soglia dei trent’anni, venivo strappata dalle calde braccia dell’Accademia per piombare in quelle meno accoglienti della “vita vera”. Protestare che le braccia accademiche non fossero così calde – nessuno fece, infatti, a gara per convincermi a continuare a fare ricerca e, anzi, dopo pochi giorni dalla discussione mi sentivo già addosso sguardi d’imbarazzo, che mi imploravano di non fare alcuna rimostranza contro un sistema che non prevede percorsi postdottorali formalizzati – era piuttosto inutile, considerando che io per prima avevo spesso ironizzato sull’aria apolitica, anacronistica e sfacciatamente indolente che si respira nei corridoi universitari.
Ero fuori, dunque, e fuori funziona che si scrive il proprio curriculum, lo si invia e si aspetta, pronti a scattare sull’attenti al primo trillo del telefono. Di curricula ne mandai a dozzine, individuando ogni istituto privato della mia città (per quelli pubblici non ero in graduatoria: mi ero affidata al sistema delle messe a disposizione, ma nutrendo poche speranze). Dopo una manciata di minuti dall’invio di una mail nella quale offrivo la mia disponibilità come insegnante, mi chiamò un istituto che non avevo mai sentito nominare e che però si trovava a pochi chilometri da casa di mia madre, dove la mia condizione di disoccupata mi costringeva a stare dopo un periodo fuori sede e uno all’estero, che avevo ingenuamente inteso come il definitivo taglio del cordone ombelicale. Il fatto che una scuola mi chiamasse immediatamente e a ridosso dell’inizio dell’anno scolastico non mi fece pensare che lavorare in quel posto non fosse particolarmente ambito: intravedere una via d’uscita a una situazione per la quale soffrivo da mesi mi rese sommamente contenta!
Mi precipitai al colloquio quello stesso pomeriggio e, nel giro di un quarto d’ora, avevo ottenuto un posto come insegnante d’italiano e storia, con le seguenti condizioni contrattuali: 15 ore a settimana, sia diurne sia serali, retribuite 10 euro l’ora con i voucher o con i contanti, con un contratto di collaborazione che poteva essere rescisso in ogni momento e che non prevedeva nessuna copertura assistenziale (le ferie e la malattia non sarebbero state retribuite: in sostanza, mi si prospettava un lavoro quasi a cottimo!); la ricreazione non era inoltre pagata, perché «è una pausa anche per voi». Dato che così avrei avuto uno stipendio di 600 euro al mese, chiesi di poter ottenere più ore, ma mi venne risposto che il resto era già sistemato: molti professori della pubblica usano, infatti, quell’istituto per arrotondare.
Mi resi presto conto che avere più ore avrebbe significato una vita votata all’insonnia; già così mi ritrovavo a lavorare anche fino a tarda notte, dato che parallelamente continuavo a dedicarmi alla ricerca accademica (ovviamente gratis). A dispetto dei luoghi comuni sulla fannullaggine degli insegnanti, lavorare 15 ore in classe significa lavorarne altre 15 a casa per preparare le lezioni e per correggere le verifiche. Il paradosso degli istituti di recupero anni scolastici è che, pur avendo “clienti” (così sono definiti i fruitori delle lezioni) incapaci di elaborare le forme più elementari di espressione verbale e di scrittura, la mole di lavoro imposta all’insegnante è enorme, in quanto l’attività didattica di lettere prevede un densissimo programma di letteratura e di storia dalla prima alla quinta, per classi che arrivano a contenere trenta persone iscritte a tutti gli indirizzi scolastici, dal liceo classico ai metalmeccanici. Il professore deve inoltre provvedere da sé al reperimento dei libri di testo e non può imporne l’acquisto agli studenti che, d’altro canto, non hanno nemmeno l’obbligo di frequenza. L’auspicio ripetutamente esibito dalla dirigenza è, non a caso, che la lezione sostituisca in toto il libro, in modo che lo studio individuale si riduca (quando va bene) alla lettura della pappardella precotta preparata dal docente, che in molti casi si sgrava a propria volta della preparazione delle lezioni dettando dei riassunti in classe.
Già nella prima settimana rimasi sconcertata dall’incapacità degli studenti di quinta superiore di scegliere un autore della letteratura italiana e di riassumerne brevemente vita e poetica (con il libro a disposizione!); uno di questi mascherò l’imbarazzo per l’impreparazione esibendo un arrogante disappunto e mandandomi, molto coloritamente, a quel paese. Dopo quell’episodio, mi domandai come degli studenti che rasentavano l’analfabetismo potessero sostenere l’esame di Stato di fronte a una commissione vera. Non dovetti indagare molto per scoprire il lato più sommerso di un sistema che già mi sembrava al limite del legale; e in questo lato più sommerso entra in gioco la questione economica. Ogni iscritto dell’istituto paga mediamente 5000 euro per l’iscrizione, cifra che comunque varia a seconda della quantità degli anni da recuperare (esempio: uno studente che dalla seconda vuol passare alla quinta paga più di chi vuole “solo” frequentare due anni in uno). A questa cifra – già esorbitante per l’istruzione di secondo grado e per un’istruzione così scadente, visto lo svilimento al quale è sottoposto il corpo docenti –, si aggiungono i soldi da spendere per le trasferte. Perché il titolo di studio abbia valore legale, questi istituti devono, infatti, appoggiarsi a scuole paritarie, scuole molto glamour, in genere frequentate dai calciatori e in genere localizzate nel centro e nel sud d’Italia. Per farlo, è però imposta la frequentazione delle loro lezioni, che vengono concentrate in una settimana al mese. Vista l’ingente spesa (viaggio più una settimana d’albergo), le trasferte implicano un’ulteriore scrematura classista: tra i già abbienti recuperatori di anni scolastici, solo i più benestanti possono diplomarsi in queste scuole glamour. Gli altri devono affidarsi alle paritarie generiche, considerate evidentemente meno accomodanti, oppure alle pubbliche, e in quest’ultimo caso la percentuale dei respinti aumenta vertiginosamente.
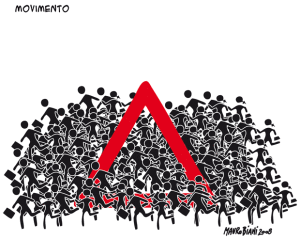
Non sono riuscita a capire come avvenga precisamente l’esame di maturità, ma ho raccolto diverse testimonianze sugli esami in itinere, che sono quelli di passaggio da un anno scolastico all’altro. Agli scritti si può copiare sfacciatamente, talvolta con la complicità degli esaminatori che passano le soluzioni sottobanco (i retroscena di questi esami sono emersi così spontaneamente durante una discussione in classe che non ho motivo di ritenerli romanzati). Eventuali carenze riscontrate possono essere facilmente rimediate all’orale, che si basa interamente sull’esposizione di una tesina preparata dallo sfruttato docente rimasto nella sede dell’istituto di recupero. Ultimo dettaglio, raggelante: perché la messinscena sia credibile – perché, cioè, lo studente sia ritenuto davvero un iscritto dll’istituto paritario marchigiano o laziale –, questo deve cambiare residenza, prendendola in luoghi fantasma designati dalla scuola. In questo modo, la percentuale di promozioni rasenta il 100%, mentre i pochi bocciati possono godere della formula “soddisfatti o rimborsati”, frequentando così un altro anno gratuitamente (formula che incentiva la scuola a prodigarsi in ogni modo affinché l’anno dopo non ci sia un utente non pagante).
Questo sistema che li imbocca e li stravizia li porta a trattare l’insegnante al pari di uno sguattero al loro servizio. Più di una volta, in classi di studenti intenti a masticare pizza o a farsi i selfie, mi sono sentita rinfacciare che il mio lavoro era legato a doppio filo alle loro rette, che per me alle pubbliche non c’era posto, e che, dunque, non avevo il diritto di farli sentire ignoranti perché, per esempio, scambiavano Lutero per Luther King (una ragazza mi chiese come potesse un tedesco essere nero…) o perché non sapevano, in quinta, distinguere il nome dall’articolo. La loro arroganza è supportata dai genitori e avvallata, tacitamente o smaccatamente, dalla dirigenza, che non esita a far chiamare gli insegnanti su delazione di qualcuno. A me è capitato di essere convocata in presidenza perché non avevo predisposto la piegatura a metà del foglio durante un tema in classe. Quando mi azzardai a far notare che il foglio a metà mi sembrava l’ultimo dei problemi, a fronte di temi dai contenuti e dalle forme terrificanti, fui zittita in malo modo. Una mattina un sedicenne, con degli evidenti disturbi psichici e con due pupille che sembravano scritturate per Trainspotting, iniziò a toccarsi durante una lezione, farfugliando frasi incomprensibili. Spaventata, cercai di raggiungere la porta, ma fui bloccata da un muro di banchi, mossi da una manciata di ragazzi sghignazzanti.
In una realtà del genere, il professore è privato di tutti i normali strumenti che disincentivano lo studente a comportarsi come se non avesse ancora assunto la posizione eretta: richiami, note sul registro (i registri non ci sono), voti, insufficienze, bocciature, compiti. Un giorno, al colmo dell’umiliazione e della frustrazione per i miei anni con Ariosto ora messi al servizio di quello che reputavo il massimo degrado dell’istruzione scolastica e che mi aveva portato a perdere molto inelegantemente la pazienza con lo sballone svalvolato, riversai su un pranzo con le mie amiche tutte le recriminazioni e le lacrime che non avevo ancora sfogato, valutando con loro ogni espediente (anche sindacale) per restituire al mittente l’invito ad andare a quel paese ed estenderlo all’intero istituto. Lo potei fare poche settimane dopo, quando una scuola pubblica mi chiamò: ero così abbattuta che, nella speranza che la telefonata fosse quello che effettivamente fu, risposi in classe, di fronte a cinquanta occhi basiti che mi fissavano. Potevo finalmente abbandonare quell’inferno. La degna conclusione di un’esperienza terrificante arrivò in un ufficio della CGIL, quando, nel momento di far vidimare le mie dimissioni, scoprii che il mio contratto non risultava registrato all’ufficio provinciale. Avevo, insomma, lavorato in nero.
Pur avendo smaltito in poco tempo l’orrore e lo stress di quei mesi tremendi, persevero nell’indignazione bruciante verso uno Stato complice della sopravvivenza e della perpetuazione di un parcheggio di ripetenti che banalizza in modi così biechi il mestiere dell’insegnante e il valore della formazione, riducendola a una compravendita di pezzi di carta e a una monetizzazione del tempo (infatti, uno dei motti di questi posti è che il tempo è denaro). Se una piccola percentuale di iscritti è lì perché il pezzo di carta è indispensabile alla continuazione di un’attività di famiglia, i più sono invece spinti da genitori che scalpitano all’idea che sulla carriera del figlio resti l’ignominia indelebile della bocciatura e dell’anno perso. Il dato allarmante è che l’inattitudine dei figli verso lo studio non ridimensiona i sogni di gloria dei genitori, che vogliono discendenti avvocati o commercialisti o ingegneri. Alcuni studenti di “quinta” (ricordo che per “quinta” si può intendere anche essere ancora in seconda) si informavano sugli open day di prestigiose università private, afflitti dal pensiero di deludere gli ambiziosi progetti genitoriali. L’infamia del fallimento, insomma, non è contemplata nella scuola turbocapitalista e le giustamente vituperate orecchie d’asino inflitte ai bambini da una scuola autoritaria ormai tramontata sono ora trasferite al tapino insegnante, biasimato se, per esempio, non ritiene che far piegare a metà il foglio durante il tema costituisca l’essenza stessa dell’esperienza scolastica.
bruciante verso uno Stato complice della sopravvivenza e della perpetuazione di un parcheggio di ripetenti che banalizza in modi così biechi il mestiere dell’insegnante e il valore della formazione, riducendola a una compravendita di pezzi di carta e a una monetizzazione del tempo (infatti, uno dei motti di questi posti è che il tempo è denaro). Se una piccola percentuale di iscritti è lì perché il pezzo di carta è indispensabile alla continuazione di un’attività di famiglia, i più sono invece spinti da genitori che scalpitano all’idea che sulla carriera del figlio resti l’ignominia indelebile della bocciatura e dell’anno perso. Il dato allarmante è che l’inattitudine dei figli verso lo studio non ridimensiona i sogni di gloria dei genitori, che vogliono discendenti avvocati o commercialisti o ingegneri. Alcuni studenti di “quinta” (ricordo che per “quinta” si può intendere anche essere ancora in seconda) si informavano sugli open day di prestigiose università private, afflitti dal pensiero di deludere gli ambiziosi progetti genitoriali. L’infamia del fallimento, insomma, non è contemplata nella scuola turbocapitalista e le giustamente vituperate orecchie d’asino inflitte ai bambini da una scuola autoritaria ormai tramontata sono ora trasferite al tapino insegnante, biasimato se, per esempio, non ritiene che far piegare a metà il foglio durante il tema costituisca l’essenza stessa dell’esperienza scolastica.





