Dio, liberaci dalla malattia, dalla fame, dalla guerra
dicembre 1, 2020 in Approfondimenti, Recensioni da Mario Baldoli
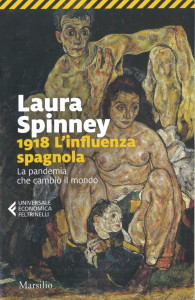 L’umanità ha sempre avuto una compagna fedele: la malattia. Dal fondo del Medioevo giunge la voce: A peste, fame et bello, libera nos Domine.
L’umanità ha sempre avuto una compagna fedele: la malattia. Dal fondo del Medioevo giunge la voce: A peste, fame et bello, libera nos Domine.
Circa un millennio dopo siamo ancora d’accordo. Loro chiamavano molte malattie col nome generico di peste. Ora, scoperta l’esistenza del virus, ne contempliamo la bella corona, ma viviamo come loro la nostra pandemia, cioè una epidemia che viaggia in tutto il mondo, prende sottobraccio altre malattie, miete le sue vittime, per ora più di un milione, e sparge il suo dolore come va il seme in un campo.
Sappiamo della peste di Pericle, di quella di Giustiniano, che tuttavia non raggiunsero il mondo intero, di più della peste che nel 1346 arrivò (forse dalla Mongolia): la peste nera, una pandemia che uccise un terzo, forse la metà della popolazione del mondo.
E’ la cornice che dà il via due anni dopo al Decameron di Boccaccio che ci introduce in una Firenze desolata e sconvolta. Anche allora fu l’isolamento in due ville di campagna a salvare sette “vaghe” giovinette e tre giovani che si incontrano in una chiesa. Quella peste ebbe in Europa tre o quattro ondate micidiali e continuò poi a circolare, in maniera più o meno intensa, in luoghi più che in altri, fino ad arrivare al 1630, la peste descritta da Manzoni.
Secondo lo storico Braudel la peste fu la struttura della metà del XVI secolo. Intanto passavano tifo e vaiolo, nell’800 arrivò il colera, infine esplose la “madre di tutte le pandemie”, come la definisce Laura Spinney in 1918, L’influenza spagnola, la pandemia che cambiò il mondo, Marsilio editore.
La spagnola sembrava, come a molti all’inizio del coronavirus, una normale influenza seguita da una normale polmonite, ma presto ci si accorse che portava anche emorragia polmonare, febbre tifoide, tubercolosi e rapidamente la morte. La spagnola arrivò nella primavera nel 1918 con un’ondata piuttosto lieve, poi divenne una pandemia incontrollabile tra l’autunno e l’inverno del 1919. Dopo una breve tregua nella primavera del ’19 vi fu una terza ondata.
Fu la pandemia del XX secolo. Dall’autunno del 1918 iniziò a diffondersi dall’Europa nel resto del mondo dove continuò a vagare per altri cinque anni circa, mietendo vittime soprattutto in India e Cina dove ci sarebbe stato qualche milione di morti. In quegli anni il tasso di fertilità crollò, anche le donne incinte ne erano colpite. Poi la vita riprese rigogliosa com’era avvenuto in tutte le epidemie precedenti.
Infine il virus perse forza, capita quando non riesce ad infettare sopravvissuti e superstiti, e lo sostituirono i soliti vecchi amici, il tifo, il vaiolo e il colera.
Sul numero dei morti, come ora, c’è la massima incertezza: 30-100 milioni? Solo in Russia sembra che i morti fossero 450.000, nessuno può sapere dell’Asia. Certamente la pandemia fece molte più vittime che la guerra, avendo a disposizione circa 2 miliardi di persone da mietere. Ma i morti in guerra si onorano con le medaglie, i monumenti, i cimiteri, la riscoperta dei luoghi; la spagnola è dimenticata anche se cambiò a fondo la vita dell’Europa.
Laura Spinney è una giornalista scientifica, quindi evita il rigore degli storici, e procede attraverso vari contesti, atteggiamenti mentali, la depressione, i suicidi, il dolore, le testimonianze degli artisti, anche qualche caso umano, le sue pagine indugiano muovendo verso il centro del male.
L’umanità si preoccupò poco del paziente 0, anche perché era il quarto anno di guerra, fame, scioperi e ammutinamenti facevano notizia. La morte di chi non combatteva si coagulava intorno alle degradate condizioni ambientali, nella miseria, nella debolezza, facendo più vittime fra i giovani che tra i vecchi, tra i poveri che tra i ricchi.
Secondo gli studi attuali, il paziente 0 potrebbe essere un soldato che si presentò il 4 marzo del ’18 nell’infermeria di un campo di reclutamento nel Kansas, con mal di gola, febbre e mal di testa. Lo stesso giorno l’infermeria si trovò a gestire più di cento casi simili, nelle settimane successive si requisì un hangar per sistemarli tutti. Ma gli Stati Uniti solo allora entravano in guerra, quindi la pandemia non sarebbe dipesa, almeno all’inizio, dalla guerra.
Come per ogni catastrofe si cercò un nome, se ne trovò uno senza senso: La spagnola, dovuto al fatto che per primi ne parlarono i giornali spagnoli (la Spagna non era in guerra) liberi dalla censura sulla stampa dei paesi belligeranti. Naturalmente ci fu chi cominciò anche a chiamarla “influenza napoletana” così come i francesi chiamavano la sifilide “mal napoletano” mentre il resto del mondo preferiva “mal francese”.
La medicina clinica era agli inizi e le cure andavano da quelle della stregoneria ad esperimenti a base di arsenico, salnitro, mercurio.
Nel frattempo emergeva, contrastata, la teoria dei germi, mentre gli strumenti dell’epoca non permettevano di cogliere il virus. L’orgoglio della scienza positivistica andò in pezzi: la medicina, la fisica, la chimica si rivelavano incapaci di fronte alla malattia. Isolamento e quarantena erano le medicine sicure.

G. Klimt, La Medicina (dipinto perduto)
L’Europa cambiava. Cambiò la pittura: sembra che Edvard Munch abbia dipinto L’urlo dopo la malattia, e nella convalescenza fece una serie di autoritratti in cui appare scheletrico e giallastro. Klimt dipinse il quadro Medicina, quadro perduto, lui colpito prima da ictus e poi – sembra- dalla spagnola. Nel settembre del 1918 T. S. Eliot pubblicò la poesia Sweeney tra gli usignoli:
Il tenebroso Orione e il Cane
si sono velati; gli oceani contratti azzittiti;
Colei che indossa il mantello spagnolo
Tenta di mettersi a sedere sulle ginocchia di Sweeney.
A Londra Eliot, colpito dalla malattia come la moglie descrisse la città spettrale e senza vita, diventata poi La terra desolata (1925).
L’economista inglese John Maynard Keynes in Le conseguenze economiche della pace (1919) descrisse la situazione dei Paesi sconfitti: Nei mesi scorsi le notizie sulle condizioni sanitarie degli imperi centrali sono state di natura tale da ottundere l’immaginazione, e sembra quasi, citandole, di peccare di sentimentalismo.
Ernst Junger che faceva parte di un plotone d’assalto scrisse di un battaglione che doveva dare loro il cambio e che “era stato quasi interamente messo fuori combattimento dalla malattia”.
Stefan Zweig, tornando in Austria, nota che sul treno tutti avevano un aspetto smunto, affamato, cencioso, le uniformi sdrucite pendevano da spalle cadenti. Tutte le cinghie per alzare e abbassare i finestrini erano state tagliate via perché ogni pezzetto di cuoio valeva un tesoro, i sedili erano devastati dai coltelli per ricavare un lembo di stoffa, i portacenere erano stati rubati per quel po’ di valore che aveva il metallo.
Il libro, arrivato ora alla seconda edizione, non dice della pandemia di oggi, ma chi vuole può trovare, rabbrividendo, qualche collegamento.





